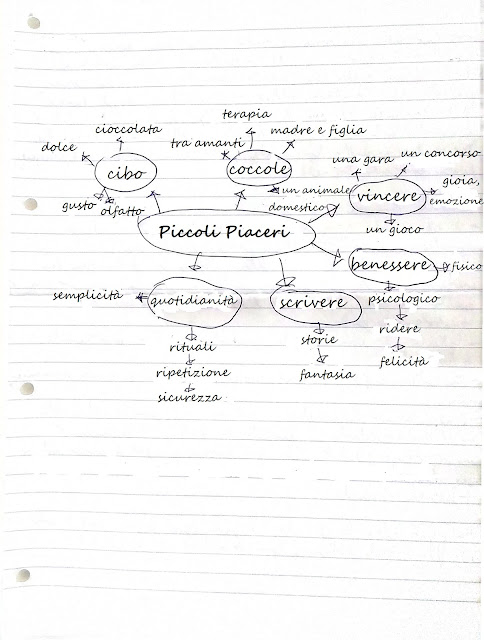Caterina dice che aspetta ogni mercoledì a
partire dal mercoledì sera. Che è il suo piccolo momento di piacere. Io non mi
faccio illusioni, però: dice tante cose. Quando arrivo ha già messo al loro
posto i pezzi sulla scacchiera e i cuscini, visto che giochiamo sul pavimento e
ogni partita dura un’ora o più.
“Non tocca a me il nero” faccio, come ogni
volta.
“Si invece” dice lei, accarezzando i suoi
pedoni bianchi come se fossero un piccolo esercito del bene. Le piace sentirsi buona, pura,
pulita. Come una scacchiera con i pezzi ben allineati prima di giocare, o un
foglio bianco su cui nessuno ha ancora scritto. Caterina dice che allora,
all’inizio, è tutto possibile; poi succede qualcosa, la storia si guasta, e non
si può più tornare indietro.
Io protesto senza troppa convinzione, come ogni volta,
poi come ogni volta cedo e prendo il nero. A me piace farla felice.
Caterina
sorride e si sdraia a pancia in giù sul pavimento, senza attendere che mi sieda
muove uno dei suoi cavalli. Scuoto la testa. La giovinezza non ha pazienza,
vuole subito entrare nel vivo delle cose. Io mi siedo sul cuscino, con le gambe
allungate di lato, e sposto uno dei miei pedoni. Mi sono sempre stati
simpatici, così piccoli e tutti uguali, eppure ognuno sulla sua riga, dritto
per la sua strada. La gente tende a sottovalutarli, preferendo i pezzi più
“importanti” e con più libertà di movimento sulla scacchiera. Per me invece,
perdere anche soltanto uno di quei piccoli soldati è quasi doloroso.
Caterina
risponde alla mia mossa. Io non le bado, preparo la mia strategia con la
saggezza degli anni, certa che perfino lei non oserà rischiare, non così
presto. Infatti preferisce non rovinare la storia, o la partita.
All’inizio
giochiamo in silenzio, come al solito, godendo ciascuna della presenza
dell’altra. Fuori dalla finestra la siepe di biancospino, coi fiori bianchi
odorosi di maggio, ci protegge come le mura di un castello incantato,
lasciandomi credere che questo sia davvero il suo – il nostro – piccolo momento
di piacere. Fuori di qui, altrove, la vita guasta le storie. Qui no, non di
mercoledì pomeriggio almeno.
Caterina fa
la sua mossa e poi mi guarda, fremendo d’impazienza. Si calmerà, più avanti, lo
so; per ora, ogni mossa le sembra una scelta facile. Sposto uno dei miei
alfieri per metterla un po’ in difficoltà.
“E ora che dici?”
le chiedo con un sorriso sornione. Lei sbuffa, si puntella sui gomiti e
appoggia il mento sul palmo della destra, scrutando la scacchiera. Mi pare
quasi di vedere, dietro i suoi occhi chiari, tutte le mosse che sta
considerando assieme alle mie possibili risposte. Distolgo lo sguardo con
discrezione, voglio lasciarla pensare in pace. Sul comodino, accanto al letto,
la copia di “Piccole donne” che le ho regalato per il suo compleanno sta prendendo
polvere.
“Sei ancora
ferma a pagina novantasette?” le chiedo.
Lei
annuisce con un mugolio disperato. So cosa avviene a pagina novantasette: a
casa ho una copia della stessa edizione. A pagina novantasette, Amy brucia il
libro di Jo.
Per Caterina,
che si era innamorata a prima vista della parola scritta, che a poco più di sei
anni aveva deciso di voler fare la scrittrice, per Caterina che era felice ogni
volta che prendeva in mano la penna o che leggeva una storia, il gesto di Amy
era stato un affronto imperdonabile. E come Jo si era arrabbiata molto con la
piccola donna, di quella rabbia ostinata di cui sono capaci soltanto i bambini.
Fosse stata una sua amica, Caterina avrebbe smesso di parlare con Amy; dato che
era un personaggio in un libro, aveva semplicemente smesso di leggere.
“Quanto
tempo è passato? Dovresti fare la pace con lei” le dico. “Mi piacerebbe che lo
finissi. Così potremmo parlarne.”
Caterina
non risponde. So di aver toccato un tasto dolente. Eppure è un peccato: le ho
regalato quel libro perché ci unisse, non perché ci separasse.
Siamo
entrambe, in un certo senso, piccole donne. Anche se lei non lo rimarrà ancora
a lungo.
Caterina a
dodici anni già sembra un’adulta in miniatura. Indossa sempre quei vestiti
aderenti, moderni, che io alla sua età non avrei mai potuto immaginarmi addosso.
Anzi, me ne sarei vergognata. Oggi ha una blusa bianca, scollata, e una
minigonna in jeans. I piedi, fasciati in collant color pelle, dondolano nudi al
di sopra della schiena. Sulla bocca imbronciata ha un velo di lucidalabbra rosa;
il massimo che le sia permesso, per ora. La immagino guardare i trucchi di sua
madre con desiderio e trepidazione, come tutte le bambine della sua età. Come
facevo anch’io in un altro tempo, quando però i trucchi erano pochi e i soldi
da spendere in simili lussi ancora meno. Guardavo mia madre, riflessa nello
specchio, tingersi le labbra di rosso con parsimonia e indossare la collana di
perle. Quel rossetto, quelle perle, erano tesori preziosi, da usare soltanto in
occasioni speciali. Era bella, mia madre. Io la guardavo e mi immaginavo allo
specchio come lei, bella e alta come non sarei mai stata. Dove è finito quel
tocco di rosso? È sbiadito in una fotografia in bianco e nero, ma è vivo più
del presente nella mia memoria.
All’improvviso
mi viene voglia di raccontarglielo, perché qualcuno dopo di me lo possa
ricordare. Caterina ascolta, annuisce condiscendente; però, dopo poco, fa: “tocca
a te, nonna.”
Non c’è
posto per il rosso, negli scacchi.
Mi sono
distratta. Le chiedo di mostrarmi la sua ultima mossa, lei me la indica con un
dito. Mi sembra impossibile ma già ci sono dei pezzi fuori dalla scacchiera,
sia neri che bianchi. Lei ha sacrificato quasi tutto l’esercito di pedoni a cui
sembrava tenere così tanto, ma almeno ha ancora entrambi i cavalli, i suoi
preferiti. Dei neri, mancano all’appello un cavallo, un alfiere, e – ahi – due
dei miei piccoli, coraggiosi pedoni. Li accarezzo, vorrei quasi sussurrare
loro: “siete stati bravi, non vi dimenticherò”.
Caterina mi
guarda, in attesa. Rifletto sulla mia prossima mossa e nel frattempo lei si
rilassa, e come sempre a questo punto diventa ciarliera. Mi racconta della
scuola, delle amiche, del fidanzato che ancora non ha ma che spera di
conquistare, delle storie che ha scritto. Dice che vuole leggermene qualcuna,
forse mercoledì prossimo, o quello dopo, quando riesce a finirle. Dice che mi
piaceranno.
Quando la
partita termina con Caterina che dichiara “scacco matto”, mi sembra impossibile
che sia già passata un’ora. Mi sembra impossibile che sia già passata una vita
intera. Fino a pochi istanti fa, ero io ad avere dodici anni e a giocare a
scacchi con mio padre. Il tempo scorre così in fretta.
Lei si alza
da terra prima di me e viene a darmi una mano. Io sgranchisco le mie gambe
storte, poi mi faccio aiutare a rimettermi in piedi. Siamo entrambe piccole
donne, ma lei ormai mi ha superata in altezza. Non posso che esserne
orgogliosa. Caterina diventerà bella e alta come mia madre, come la donna di
cui porta il nome, e il solo pensiero mi procura un piccolo brivido di piacere.
“Già non
vedo l’ora che sia mercoledì prossimo” mi confessa ansiosa. Un po’ la capisco:
una settimana è un periodo di tempo molto lungo quando si ha la sua età. Per me
invece non è che una manciata di momenti.
Prima di
congedarmi accenno al libro sul comodino. “Per favore, perdonala. Fallo per
me.” Non le dico che è solo un personaggio in un libro, che succederanno cose
più gravi nella sua vita per le quali varrà la pena arrabbiarsi. Lei lo sta
prendendo molto sul serio, e va bene così, alla sua età.
Caterina
mordicchia il labbro inferiore velato di rosa. “Jo la perdona?” mi chiede.
“Oh,
furbetta! Devi scoprirlo da sola” faccio, mentre mi accompagna alla porta. La
saluto, sperando ardentemente che la curiosità abbia il sopravvento e che lei riprenda
a leggere.
È mercoledì. Caterina è appena tornata dalla chiesa. È vestita di nero; sembra uno dei miei pedoni. Lei, che non ha mai sopportato il nero.
Tira fuori
dall’armadio la scacchiera, prepara i cuscini, dispone con cura ogni pezzo, lentamente,
anche se già sa che stavolta non verrò. Accarezza i suoi pedoni bianchi, muta.
Il suo piccolo esercito del bene. Poi inizia da sola, muove il cavallo,
attende. Guarda il cuscino vuoto. Fuori dalla finestra, la siepe di biancospino
non può più proteggerla. È successo qualcosa, la magia si è spezzata, la storia
guastata. Con un gesto rabbioso Caterina butta all’aria tutto. Bianco e nero si
confondono sulla scacchiera, entrambi gli eserciti abbattuti in una singola
mossa.
Non ha più
voglia di giocare, va a sedersi sul letto. Sul comodino, la copia di “Piccole
donne” sta prendendo polvere. Caterina l’afferra, passa una mano sulla
copertina. La mano le si riempie di polvere e le ricorda una frase che ha
sentito oggi, in chiesa. Si spaventa, la pulisce in fretta sull’abito nero e
apre il libro. A pagina novantasette, per tenere il segno, c’è una fotografia
in bianco e nero che ritrae una donna alta, bella, accanto a una bambina della
sua età. Difficile indovinare i colori di un tempo negli abiti lunghi e sui
loro volti. Difficile indovinare che cosa pensavano, cosa stavano facendo in
quello che a lei sembra un loro piccolo momento di piacere. E dev’esserlo
stato, non solo perché sorridono, ma anche perché la gente non vuole avere una
fotografia di quando è triste.
Caterina
mette da parte la foto e comincia a leggere ad alta voce, come facevo io per
lei quand’era piccola.